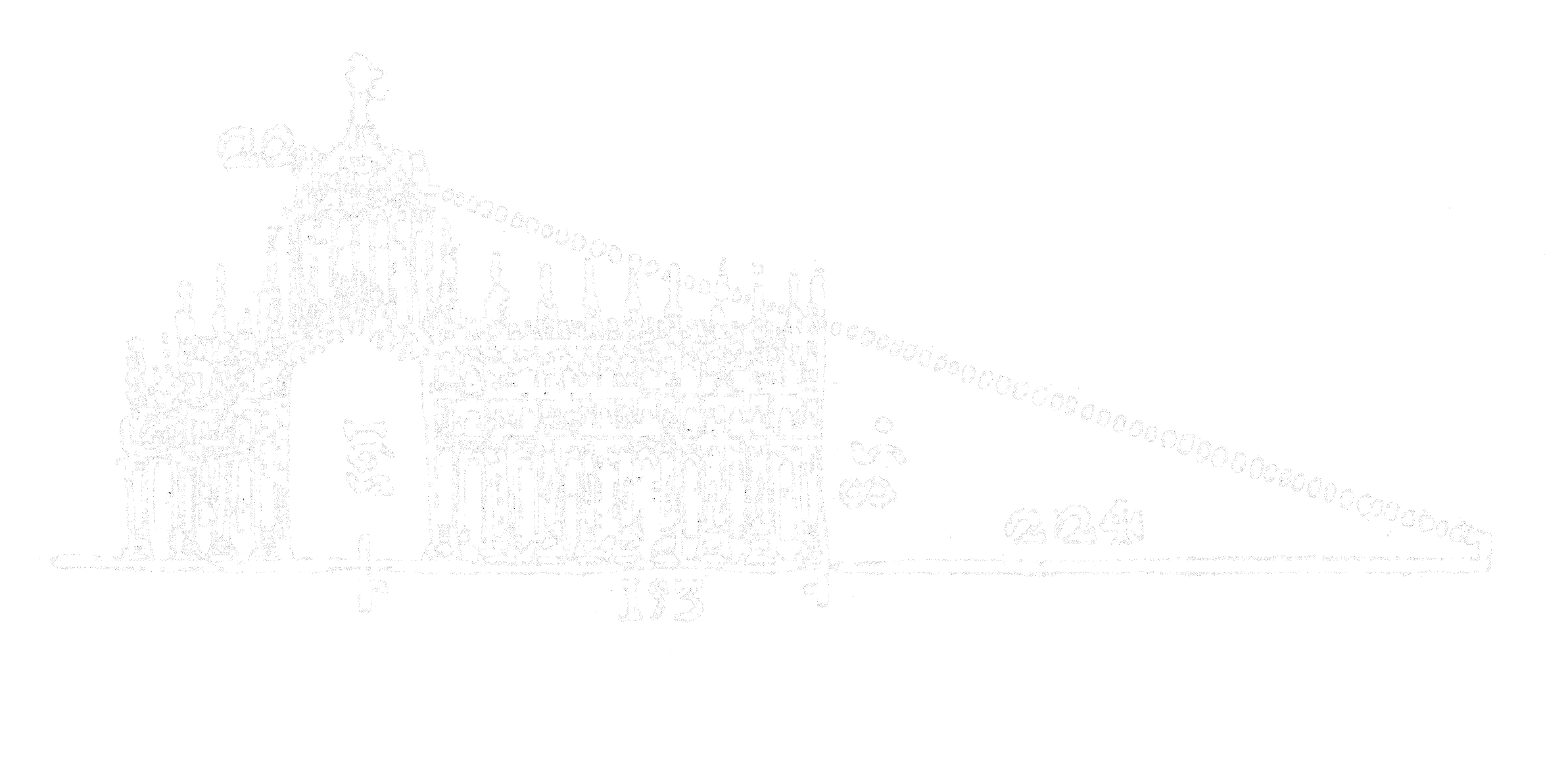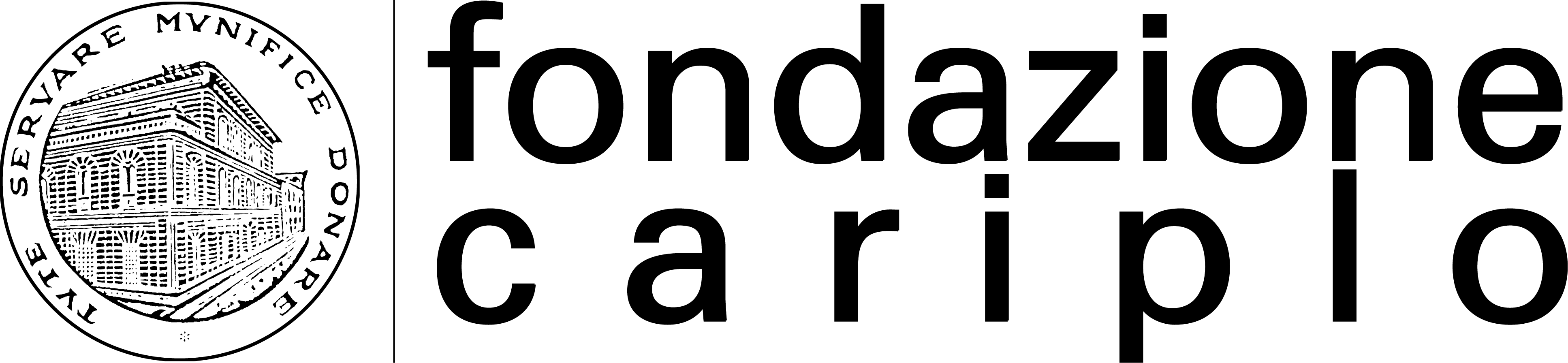Sezione trasversale di parte delle navate con studio per ponteggi
Autore
AnonimoTitolo
Sezione trasversale di parte delle navate con studio per ponteggiDatazione
[XVI secolo, ultimo quarto – XVII secolo, post 1660 ?]
Collocazione
ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 20vA
Dimensioni
240x364 mmTecnica e Supporto
Preparazione a matita, compasso; esecuzione a penna e inchiostro bruno; supporto cartaceo di grammatura leggera, filigrana vicina a Briquet n. 9722, ma con il trifoglio al di fuori del clipeo, anziché al suo interno, e la lettera G sottostante rovesciata, documentata secondo il repertorio a Bergamo nel 1592 e a Milano tra il 1600 e il 1619.
Scala
Non presenteIscrizioni
Sul verso, indicazione inventariale moderna, a matita: «II 20v a».
Notizie
Il disegno è inserito all’interno del secondo tomo della Raccolta Bianconi, conservata oggi presso l’Archivio Storico Civico di Milano, composta in dieci volumi dall’architetto, collezionista e storico Carlo Bianconi tra il 1789 e il 1796 e contenente disegni di architettura e alcune incisioni di edifici milanesi tra il XIV e il XVIII secolo. La storia del foglio si accompagna quindi con quella della Raccolta, che dopo essere passata ai Litta e poi ai Vallardi, entra nel 1872 nelle collezioni civiche milanesi, quando il Comune di Milano la acquista da Antonio Vallardi. Il disegno è inserito insieme a un altro (ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 20vB) al verso del f. 20 del tomo (presso l’Archivio Storico Civico esiste una riproduzione fotografica in bianco e nero del disegno, negativo A 4105), mentre il recto del foglio del tomo è occupato da altri due disegni (ASCMi, Raccolta Bianconi, II, ff. 20rA, 20rB).
Il foglio presenta alcune abrasioni negli angoli, forse dovute a distacco delle colle avvenuto in un momento imprecisato: si notano infatti sul verso tracce evidenti della colla usata per il fissaggio al tomo. Il margine sinistro si presenta irregolare e il foglio reca alcune grinze ai margini oltre che la traccia della piegatura centrale, oggi non più utilizzata.
La preparazione a matita è riservata alle sole parti poi ripassate a penna, con un uso del compasso molto limitato, dal momento che alcuni degli archi sono disegnati a mano libera (anche il f. 18vA presenta preparazione unicamente a matita, mentre nei fogli affini 17vA, 17C e 18vC esiste anche una preparazione a punta secca). L’esecuzione a penna e inchiostro bruno è condotta a strumento per le linee architettoniche principali, mentre a mano libera sono alcuni archi e le campiture oblique corrispondenti alle parti in sezione (questa caratteristica distanzia il disegno da quelli affini ai ff. 17vA e 17vC, ma lo avvicina ai ff. 18vA e 18vC). Campiture piene con il medesimo inchiostro caratterizzano gli elementi lignei oggetto dello studio.
Note critiche
Il disegno non ha avuto un’estesa fortuna critica, ma compare nell’inventario della Raccolta Bianconi, redatto da Isabella Balestreri (Balestreri, 1993; Balestreri 1995). Esiste nel secondo tomo della Raccolta, infatti, un piccolo gruppo di 5 disegni che recano il medesimo soggetto riproposto nelle stesse dimensioni e perfino con gli stessi particolari (ASCMi, Raccolta Bianconi, II, ff. 17vA, 17vC, 18vA, 18vC, 20vA; in Cassi Ramelli, 1965, p. 61, fig. 44 è riprodotto il disegno al f. 17rC), se si eccettua la realizzazione di un’ombreggiatura a tratteggio e la presenza di alcune iscrizioni in uno dei pezzi. Anche le caratteristiche tecniche e la carta sul quale sono realizzati sembra essere la medesima, elemento importante ai fini della datazione dei pezzi, poiché tutti recano un tipo di filigrana documentata tra l’ultimo quarto del XVI e il primo quarto del XVII secolo (si noti in particolare che i ff. 17vA, 17vC e 20vA hanno la medesima filigrana, così come i ff. 18vA e 18vC, con filigrana della stessa tipologia dei precedenti, ma con leggere varianti). Il gruppo di disegni mostra un sistema di strutture lignee tra cui si notano le capriate delle navate minori nord, poste al di sopra delle volte a reggere le falde del tetto (che Cassi Ramelli indica come provvisorie, utilizzate in fase di costruzione; Cassi Ramelli, 1965, p. 61, didascalia della fig. 44) e, inoltre, le chiavi presumibilmente metalliche inserite al di sopra dei capitelli (come si evince dalle iscrizioni con la parola «chiave», presenti nel foglio 18rC). In questo disegno sono indicate con tratteggio obliquo le murature in sezione. In corrispondenza della navata mediana e, nel caso di quella centrale, sono disegnati i ponteggi forse utili per la realizzazione delle volte stesse, che presentano anche evidenziate al tratto le parti metalliche.
Non è da escludere che i disegni siano da associare alla fase di costruzione delle prime tre campate del Duomo verso la piazza, la cui esecuzione è deliberata nel 1591 (Repishti, 2003, p. 14; a questa fase di deve almeno la posa in opera dei piloni fino alla quota delle volte), tuttavia essi potrebbero essere posteriori, se li si volesse legare alla costruzione delle volte vere e proprie, dal momento che queste non compaiono ancora costruite in un disegno di Girolamo Quadrio del 1660 (Repishti, 2003, p. 201, fig. 121).
Bibliografia
I. Balestreri, I disegni del Duomo di Milano nella Raccolta Bianconi, “Il disegno di architettura”, 7, 1993, p. 28
La Raccolta Bianconi. Disegni per Milano dal Manierismo al Barocco, a cura di I. Balestreri, Milano, 1995, p. 23