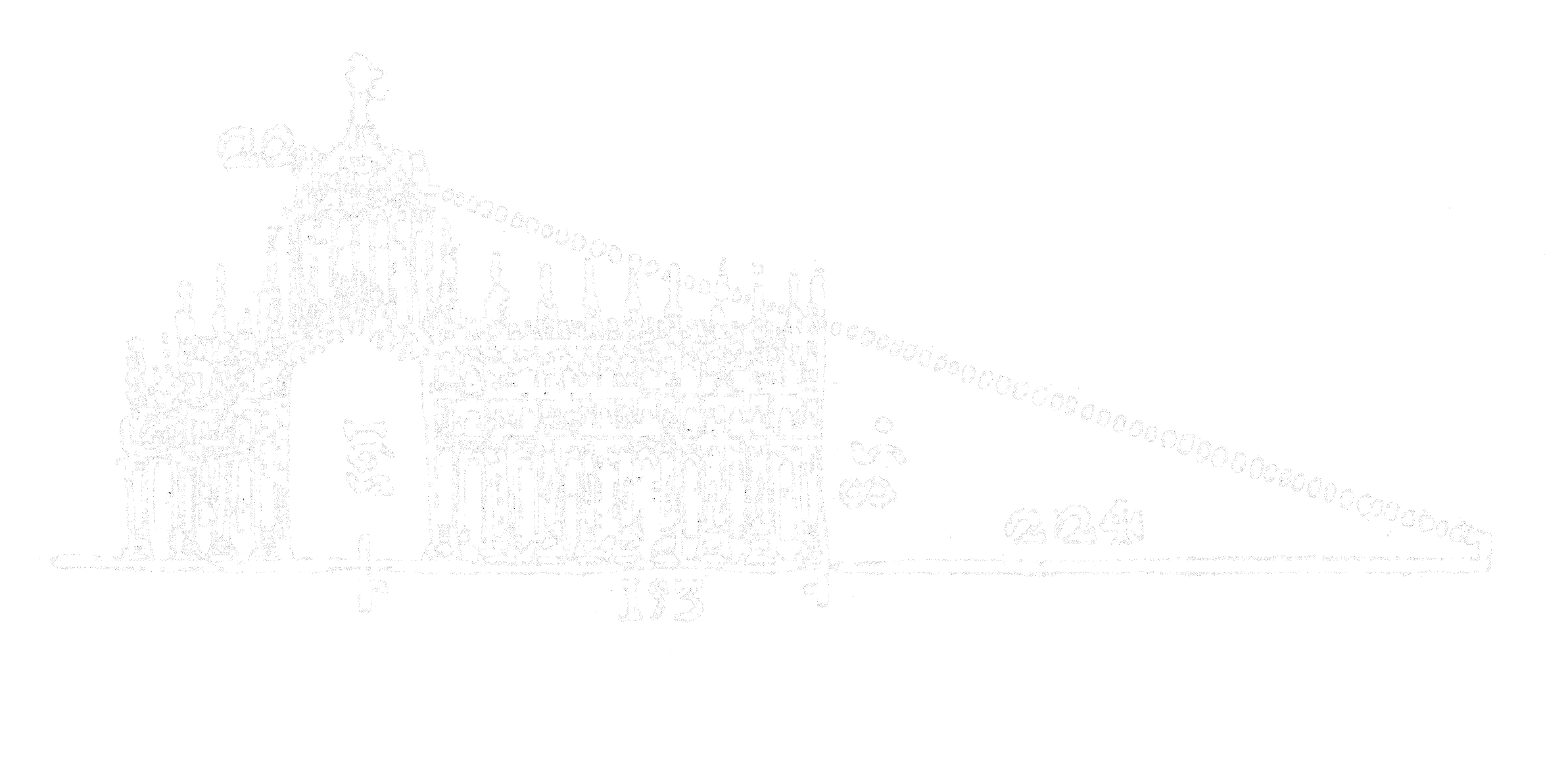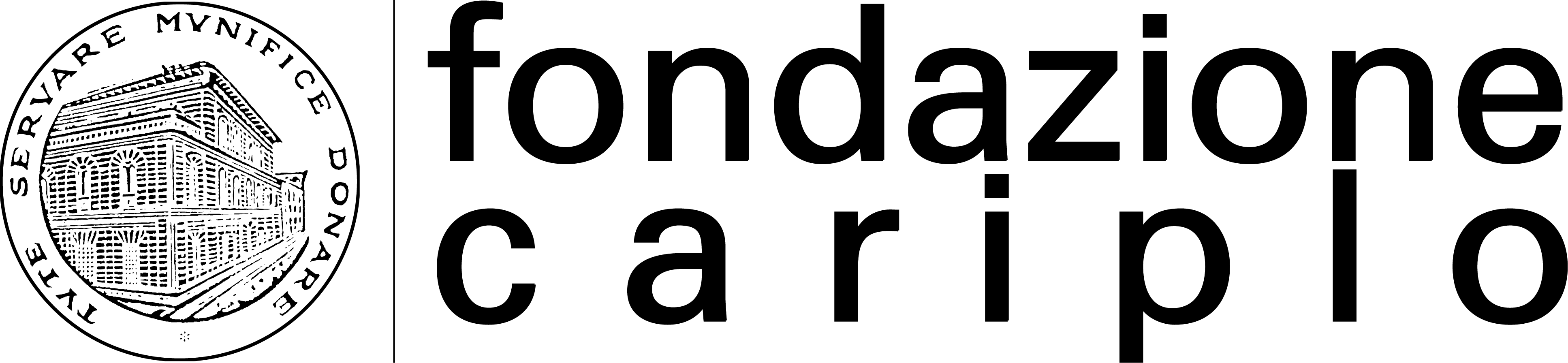Progetto per la facciata
Autore
Capitani da Sesto, Girolamo deTitolo
Progetto per la facciataDatazione
XVII secolo; 1608
Collocazione
ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 33r
Dimensioni
1250x855 mmTecnica e Supporto
Preparazione a matita, compasso; esecuzione a penna e inchiostro bruno, acquerellatura a inchiostro bruno diluito in diverse tonalità; supporto cartaceo di media grammatura, filigrana non presente.
Scala
In basso al centro, a penna e inchiostro bruno, di 30 braccia milanesiIscrizioni
In basso a destra: «Hieronimo di Capitanii da Sesto 1608».
In basso al centro, in corrispondenza della scala: «Scala di Braccia Millanese n. 30».
In basso, in corrispondenza della pianta, ai luoghi propri: alcune misure in braccia milanesi.
Sul verso: «Io Hieronimo di Capitanii da Sesto feci il presente disegno nel mese di luglio 1608»; «33»; indicazione inventariale moderna: «2 33r»; sigla di due lettere, leggibile la «B» finale.
Notizie
Il disegno è inserito all’interno del secondo tomo della Raccolta Bianconi (composta da Carlo Bianconi tra il 1789 e il 1796, passata ai Litta, poi ai Vallardi e dal 1872 al Comune di Milano) come unico pezzo al recto del f. 33 (presso l’Archivio Storico Civico esiste una riproduzione fotografica in bianco e nero del disegno, negativo A 4132), mentre il verso del foglio del tomo è occupato da altri due disegni (ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 33vA, 33vB).
Il disegno è composto su quattro fogli consunti e che mostrano macchie. Ai margini sono presenti tracce di una cornice, in corrispondenza delle quali la carta è molto imbrunita. Sul verso si notano tracce di colla che hanno creato macchie brune. In corrispondenza delle piegature piccole abrasioni, consunzione di alcune parti di inchiostro e piccoli strappi e lacune compensate con strisce di carta di supporto sul verso.
Note critiche
Nell’ambito della progettazione della facciata, l’idea di Girolamo de Capitani da Sesto si colloca in un momento particolarmente ricco di proposte, che ha interessato tutto il primo decennio del Seicento. La proposta di Girolamo de Capitani, con colonne su piedistalli, è stata letta dalla storiografia (Repishti, 2003, p. 64, 68; Bortolozzi, 2014, pp. 46-47) in dipendenza da alcune delle idee di Francesco Maria Richino, come il foglio 29r del secondo tomo della Raccolta Bianconi. Similmente a Richino, infatti, Girolamo de Capitani propone un aggetto progressivo dei piani di facciata verso il centro, arricchito dal ritmo serrato delle colonne libere poste a evidenziare i trapassi di piano, aggiungendo però piedistalli sotto le colonne e risolvendo gli spigoli esterni mediante la ripetizione del medesimo sistema di colonne libere anziché paraste binate. Questo progetto è anche uno di pochi che, similmente alla proposta di Richino, accoglie percorsi scalari nello spessore murario accanto al portale maggiore.
Queste proposte sono state poste in relazione con uno dei progetti documentati di Onorio Longhi del 1607, del quale in assenza di prove grafiche chiaramente identificabili, sappiamo dai Dibattiti (Repishti, Schofield, 2003, p. 384) del suo essere anch’esso articolato su diverse profondità, con la possibilità di avere una qualche influenza sulle idee di quegli anni che mostrano attenzione a proposte di ambito romano, segnatamente alle idee di Maderno per la facciata di Santa Susanna, forse nel caso di Girolamo de Capitani mediate da Richino (Repishti, 2003, pp. 64-65). Si pensi anche alla fortuna di alcuni elementi, come l’edicola con timpano curvilineo che inquadra il portale centrale, che Anna Bortolozzi mette in relazione alla facciata di Santa Maria in Vallicella a Roma (Bortolozzi, 2014, p. 47), sebbene il medesimo elemento non sia estraneo alla progettazione del Duomo, sia caro ai progetti di Francesco Maria Richino stesso, e sia già presente come tema in diverse prove cinquecentesche, come alcune proposte nel gruppo comunemente assegnato a Martino Bassi (per esempio BAMi, S. 148 sup., n. 10 o ancor più ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 37rA). Il rapporto del disegno di Girolamo de Capitani con le prove grafiche di Richino sembra potersi apprezzare anche dal punto di vista tecnico, in particolare nel modo di tracciare le ombre delle cornici, che si protendono vistosamente verso destra e che ricordano il modo di Richino nel più tardo foglio in ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 32r, preparatorio per l’incisione.
A questa soluzione di facciata, specialmente per l’idea del pronunciato aggetto centrale, sembra connettersi anche la proposta contenuta nel foglio F. 251 inf. n. 104 della Biblioteca Ambrosiana, ricondotto al Duomo da Francesco Repishti (Repishti, 2003, p. 64), che reca sul verso (n. 105) il nome di Giovan Battista Mangone e che è valutato dubitativamente da Anna Bortolozzi come affine alla soluzione di Onorio Longhi secondo la descrizione dei Dibattiti (Bortolozzi, 2014, p. 48, ma per una discussione su questo disegno si veda anche la scheda relativa).
Bibliografia
G. Mongeri, La facciata del Duomo di Milano e i suoi disegni antichi e moderni, “Archivio Storico Lombardo”, XIII, 1886, p. 316, p. 341 n. XI
G. Morazzoni, Il Duomo. Saggio iconografico, Milano, 1919, p. 3 n. 19
L. Grassi, Province del Barocco e del Rococò. Proposta di un lessico bibliografico di architetti in Lombardia, Milano, 1966, p. 172
I. Balestreri, I disegni del Duomo di Milano nella Raccolta Bianconi, “Il disegno di architettura”, 7, 1993, p. 28
La Raccolta Bianconi. Disegni per Milano dal Manierismo al Barocco, a cura di I. Balestreri, Milano, 1995, p. 26
F. Repishti, La facciata del Duomo di Milano (1537-1657), in F. Repishti, R. Schofield, I dibattiti per la facciata del Duomo di Milano 1582-1682. Architettura e controriforma, Milano, 2003, pp. 64-68, p. 79 fig. 62
A. Bortolozzi, Onorio Longhi e gli anni dell’esilio (1606-1611): le esperienze di un architetto romano nella Lombardia federiciana, “Arte Lombarda”, 151, 2007/3, p. 47, fig. 8
M. Fratarcangeli, G. Lerza, Architetti e maestranze lombarde a Roma (1590-1667). Tensioni e nuovi esiti formativi, Castrocielo (Fr), 2009, p. 114
A. Bortolozzi, Santi Ambrogio e Carlo al Corso. Identità, magnificenza e culto delle reliquie nella Roma del primo Seicento, Roma, 2014, pp. 46-47, fig. 19