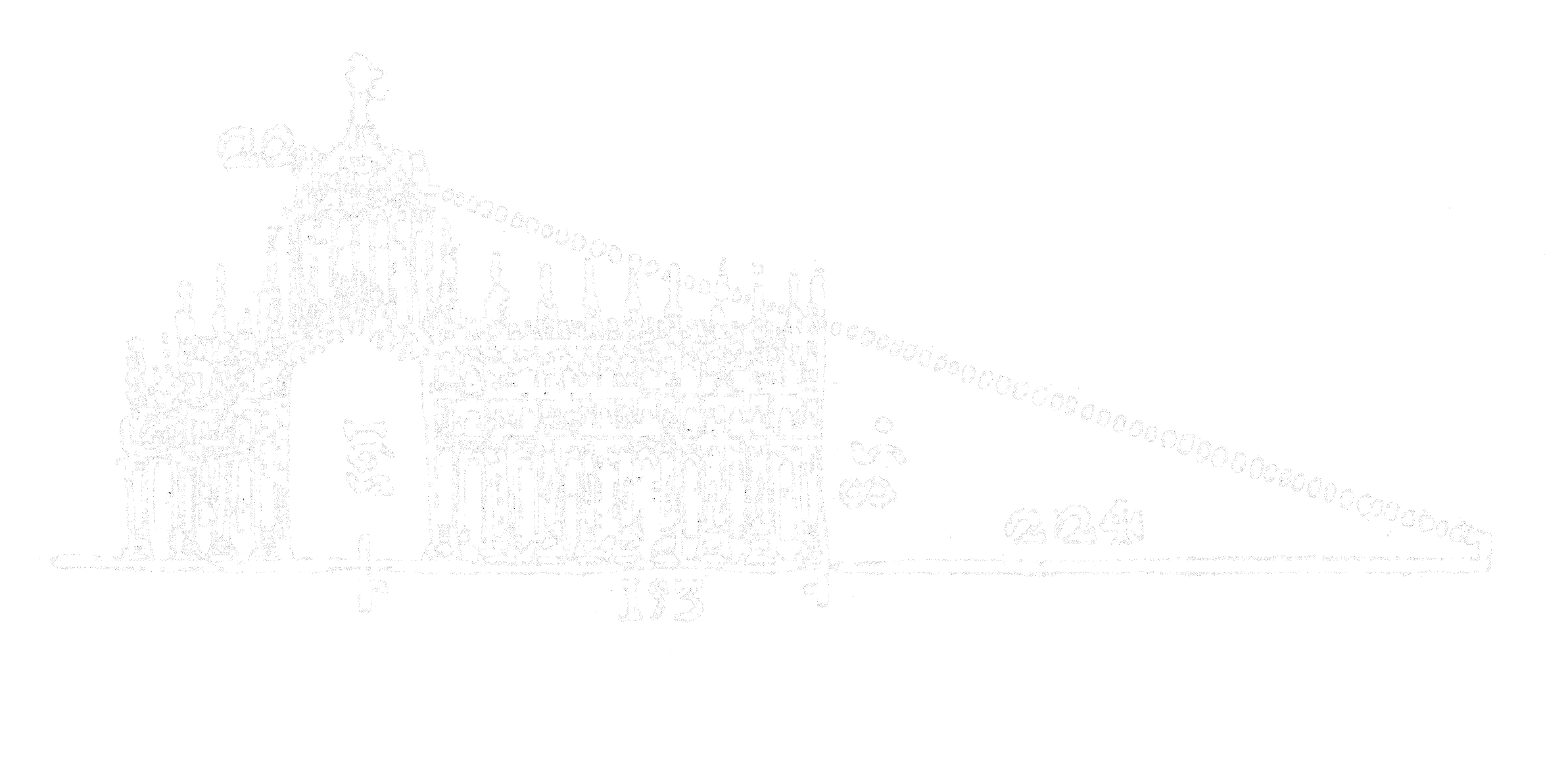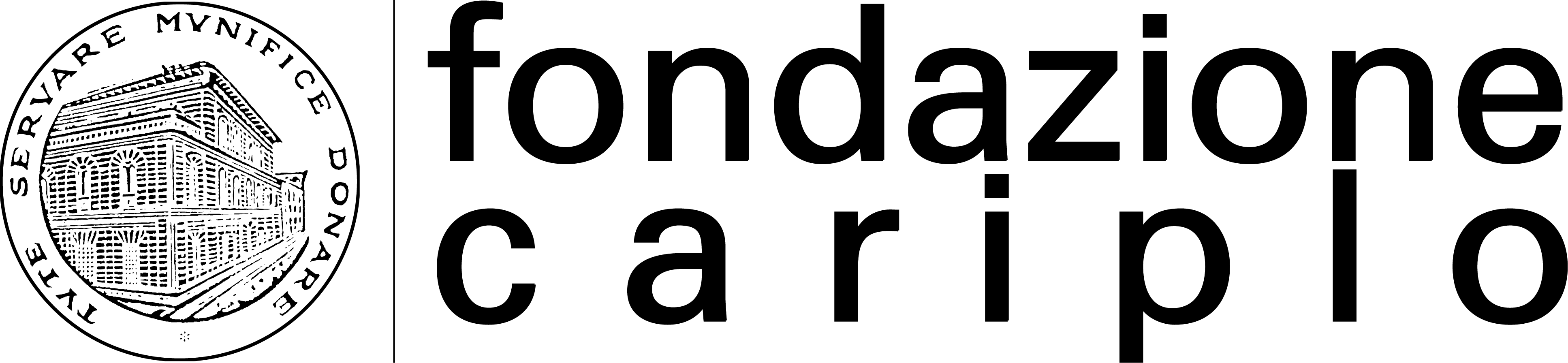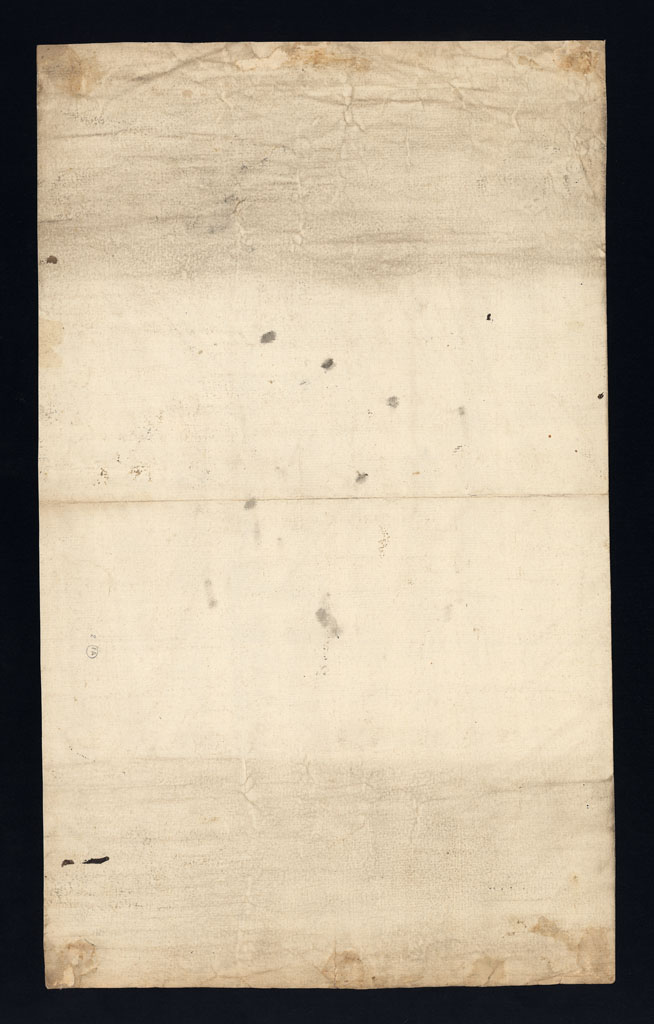Pianta del Duomo e della piazza; progetto per catafalco funebre
Autore
[Rinaldi, Tolomeo ?]; [Bisnati, Alessandro ?]Titolo
Pianta del Duomo e della piazza; progetto per catafalco funebreDatazione
XVII secolo; [(1611)1613-1616]
Collocazione
ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 1rA
Dimensioni
481x290 mmTecnica e Supporto
Preparazione a punta secca; esecuzione a penna e inchiostro bruno, acquarello ocra e rosso, matita; supporto cartaceo di media grammatura, filigrana non presente.
Scala
Nella metà inferiore, in prossimità del margine destro, disposta in verticale, di 12 braccia milanesi: composta da una linea continua a penna e inchiostro bruno, con tratti trasversali posti a distanze regolari, più fitti entro la prima unità a destra e a sinistra.Iscrizioni
In alto, al luogo proprio a sinistra della pianta, a penna e inchiostro bruno: «Corso di P[ort]a o[rienta]le».
Nella metà superiore, al luogo proprio, a sinistra della pianta: «C[orso] di S[an]to Rafaello».
Al centro, sotto la pianta, in corrispondenza della linea tratteggiata che indica la distanza tra due edifici, a penna e inchiostro bruno: «b[raza] 34 ½».
Nella metà inferiore a sinistra, ai luoghi propri, a penna e inchiostro bruno: «Contrada de borsinari», «Portico de figini».
In basso al centro, in corrispondenza della linea tratteggiata corrispondente alla distanza tra due edifici, a penna e inchiostro bruno: «b[raza] 21 ½».
Nella metà inferiore a destra, ai luoghi propri, a penna e inchiostro bruno: «Isola de fondegari», «C[orso] baretari stretti», «alla dovana».
In basso a sinistra, ai luoghi propri, a penna e inchiostro bruno: «Pescaria Vecchia», «Contrada che va alla Piazza de Mercanti».
A destra, in corrispondenza della scala originaria, a penna e inchiostro bruno: «b[raza] 12 / b[raza] 104».
Nella metà superiore a sinistra, in prossimità del margine, a matita: «li pilastri / grossi b[raza] 4 onze 3 / il risalto nel piè di onze 10 / li 4 pilastri in braza 5».
Nella metà superiore al centro, in corrispondenza del catafalco disegnato a matita, a matita: alcune cifre corrispondenti alle distanze tra le parti; «10.4 / 10.5 / 9.10» (interassi tra gli ultimi quattro piloni nord della navata centrale); «2.6» (interasse tra i piloni della navata centrale, calcolato alla quota del quart’ultimo pilone).
In alto a destra, a penna e inchiostro bruno (scuro): «3. G I».
Sul verso, indicazione inventariale moderna, a matita: «1A».
Legenda posta a destra, in prossimità del margine, con lettere capitali ai propri luoghi in corrispondenza dei locali prossimi al fianco sud della cattedrale: «A. caseta della fabrica / B. locho delle Carocie / C. Boteghe della fabrica / D. Del hospe[dal]e Magg[io]re / E. Porta della Corte».
Legenda posta in basso a sinistra, con lettere capitali ai propri luoghi, a penna e inchiostro bruno: «A. Spatio del Connago longo b[raza] 13 lar[go] b[raza] 6 / B. Spatio di M[essere] Bernardino Cavedal de b[raza] 10 et 5».
Legenda posta a destra, in prossimità del margine, a matita, lettere capitali ai propri luoghi in corrispondenza del disegno a matita al centro del capocroce della pianta: «A. [+] B. [+]» (matita scarsamente leggibile).
Notizie
Il disegno appartiene a un gruppo di piante del Duomo inserite all’interno del secondo tomo della Raccolta Bianconi, conservata oggi presso l’Archivio Storico Civico, composta in dieci volumi dall’architetto, collezionista e storico Carlo Bianconi tra il 1789 e il 1796 e contenente disegni di architettura e alcune incisioni di edifici milanesi tra il XIV e il XVIII secolo. La storia del foglio si accompagna quindi successivamente con quella della Raccolta, che dopo essere passata ai Litta e poi ai Vallardi, entra nel 1872 nelle raccolte civiche milanesi, quando il Comune la acquista da Antonio Vallardi. Il disegno è inserito insieme a un altro (ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 1rB) al recto del foglio 1 del tomo (presso l’Archivio Storico Civico esiste una riproduzione fotografica in bianco e nero del disegno, negativo A 4055), mentre il verso del foglio del tomo è vuoto.
Il disegno parrebbe essersi conservato nelle sue dimensioni originarie, se si considera la disposizione di alcune delle iscrizioni, che sembrano esservi inserite tenendo conto del margine, tuttavia lungo alcuni margini si notano tracce di una linea a matita come di contorno, similmente al f. 1rB. La carta mostra un ingiallimento più accentuato in corrispondenza dei margini superiore e inferiore, mentre sul verso si notano due fasce annerite collocate nella parte alta e nella parte bassa del foglio, oltre ad alcune macchie brune, forse di inchiostro, e le tracce della colla impiegata per l’incollaggio al tomo. È presente l’antica piegatura centrale orizzontale a metà del foglio, oggi appianata, poiché il foglio è conservato aperto.
Il foglio è preparato interamente a punta secca, anzitutto per mezzo di un tracciato di linee ortogonali di base, a partire da una linea assiale verticale centrale (poi non ripassata) e poi da una sorta di quadrettatura che non corrisponde necessariamente con i tratti poi ripassati a penna e limitata alla sola zona del disegno. A questa sono poi aggiunte le linee a punta secca corrispondenti ai tracciati che dovevano essere ripassati a penna e inchiostro bruno. Le linee sono tracciate a strumento e il compasso è utilizzato per le circonferenze corrispondenti ai piloni e semipiloni della cattedrale. L’esecuzione a penna è eseguita interamente a strumento, accurata e condotta senza sostanziali pentimenti, ma solo alcuni ripassi, mentre si nota sempre il punto di appoggio della penna maggiormente inchiostrato. L’uso dell’acquarello è invece riservato alle campiture dei pieni murari, ocra per la cattedrale e rosso per le altre strutture, alcune delle quali (botteghe) sono realizzate senza spessore, per mezzo di un tratto singolo.
Il disegno rappresenta la pianta del Duomo di Milano, apparentemente derivante, con poche varianti, dalla xilografia raffigurante l’icnografia inserita all’interno del volgarizzamento al trattato vitruviano di Cesare Cesariano edito a Como nel 1521 (C. Cesariano, Di Lucio Vitruvio Pollione De Architectura Libri Dece, Como, 1521, f. XIV), del resto più volte replicata nel corso del XVI secolo e utilizzata come base progettuale. All’interno di essa è segnalata la posizione dell’altare e quella della facciata di Santa Maria Maggiore, situata in corrispondenza della terza campata e delimitata da una linea a tratteggio. Rispetto all’icnografia di Cesariano sono già chiuse le porte laterali dei transetti ed è inoltre segnalata la porta collocata nella campata est del transetto sud, aperta dopo il 1579 (anno della chiusura della porta in testata di transetto; Marcora, 1965, p. 334). Il disegno presenta altresì la situazione urbanistica circostante il Duomo, a sud i profili del palazzo ducale e del palazzo arcivescovile, dove si nota in particolare lo spigolo della corte ducale che si protendeva verso il Duomo stesso e in direzione di collisione con il suo spigolo sud, in base all’ingombro massimo che la cattedrale avrebbe dovuto occupare, deciso già dal 1456 con la posa della colonna rossa. In corrispondenza di questi locali, segnati A B C D E e con legenda corrispondente, è delineata a tratteggio una proposta di rettificazione dello spigolo che liberi lo spazio per la facciata del Duomo. A nord si notano gli edifici verso Compedo, escluso il portico delle bollette, in corrispondenza del quale si ha uno spazio bianco corrispondente al suo ingombro, nel quale non sono infatti tracciati i gradini della cattedrale. Davanti al Duomo sono poi rappresentati il portico dei Figini con le botteghe corrispondenti, le indicazioni delle contrade e il Rebecchino (isola dei Fondegari).
Al centro della pianta della cattedrale vi è poi un piccolo disegno aggiunto a matita a mano libera rappresentante la pianta di un catafalco con un primo livello ottagonale accessibile per mezzo di quattro rampe di scale e al centro una struttura quadrangolare. A quest’aggiunta corrispondono inoltre alcune iscrizioni a matita poste lungo il margine sinistro e poi due piccoli quadrati segnati A e B con legenda apposita. Altri tratti a matita interessano la zona del coro, dove troviamo recinta la quarta campata dal fondo, con linee parallele doppie a est e ovest che potrebbero indicare la presenza di gradini. Un’altra linea a matita, continua e sottile, taglia orizzontalmente una parte delle navate, collocandosi tra la quarta e la quinta campata, a partire dall’esterno della parete nord, gira verso il coro in corrispondenza del primo pilone della navatella più esterna e poi di nuovo verso il centro in corrispondenza della quinta campata, si ferma poco dopo l’asse mediano.
Note critiche
Il disegno è stato pubblicato per la prima volta da Luca Beltrami in un opuscolo dedicato alla situazione urbanistica della piazza del Duomo dato alle stampe nel 1912 (Beltrami, 1912, oggi in Cassi Ramelli, 1964). Beltrami riproduce il ridisegno solo di una parte del foglio, corrispondente allo spigolo del palazzo ducale in collisione con la facciata e assegnando il disegno alla metà del XVI secolo, specificando che il ritrovamento di rasature di muri nel sottosuolo corrispondente ai suddetti locali ha dimostrato l’attendibilità degli elaborati grafici antichi sopravvissuti. Dopo la citazione di Beltrami il disegno non ha avuto una diffusa fortuna critica, mantenendo una collocazione cronologica alla metà del Cinquecento nelle pubblicazioni successive (Balestreri, 1993; Balestreri, 1995; Patetta, 1997), ripresa più recentemente con un’attribuzione alla bottega di Vincenzo Seregni (Sanvito, 2002); unica voce fuori dal coro quella di Rudolf Wittkower, che lo indica come appartenente al XVII secolo (Wittkower, 1974).
Si nota che già Paolo Mezzanotte, nell’ambito dell’edizione dell’inventario analitico del primo tomo della Raccolta Bianconi, aveva citato il disegno come termine di confronto per il foglio 1r del tomo I, rappresentante per l’appunto una pianta del palazzo ducale. In particolare i locali presenti nel nostro disegno a sud della cattedrale sono esattamente corrispondenti a quelli del foglio 1r del primo tomo della Raccolta, che presenta inoltre un volet nel quale è delineata la variante con il profilo del palazzo rettificato che nel nostro foglio appare a tratteggio. Si nota, addirittura, che il disegno al f. 1rA del secondo tomo Bianconi è maggiormente dettagliato, per il fatto che riporta oltre i locali segnati B, D ed E, corrispondenti al luogo delle carrozze, a una proprietà dell’Ospedale Maggiore e all’ingresso della corte dell’arengo, anche i locali di proprietà della Fabbrica del Duomo, segnati A e C e assenti dal disegno al f. 1r del primo tomo della Bianconi. I due disegni appaiono comunque indiscutibilmente correlati, permettendo quindi di avere un aggancio cronologico per il nostro foglio, poiché il disegno al f. 1r del tomo primo della Raccolta è collocato da Mezzanotte tra 1598, poiché nel palazzo compare già il teatro eretto in quell’anno in onore di Margherita d’Austria e il 1616, ovvero l’anno in cui vengono definitivamente demoliti i locali del palazzo in collisione con la facciata della cattedrale, che diviene quindi il terminus ante quem anche per il nostro disegno. L’arco cronologico si restringe ulteriormente se si considerano le vicende che portarono a questi interventi e che vedono coinvolti in particolare Alessandro Bisnati e Tolomeo Rinaldi tra il 1613 e il 1614 (una sintesi in Repishti, 2003, pp. 72-73, con una proposta per Tolomeo Rinaldi per il disegno in Raccolta Bianconi, I, f. 1r, p. 102, fig. 77). Una datazione in questi termini potrebbe essere confermata anche dall’assenza dal disegno del portico delle bollette, demolito nel 1614, del quale però è lasciato in bianco l’ingombro, sintomo forse di un intervento appena eseguito (?).
Alcune considerazioni possono essere effettuate rispetto alla presenza delle botteghe sulla piazza, che trovano corrispondenza in due disegno conservati presso la Biblioteca Ambrosiana, all’interno della Raccola Ferrari (BAMi, S. 148 sup. in. 58 e 60; Gatti Perer, 1985, p. 21, figg. 7-8; p. 23), databili all’inizio del Seicento in base alla disposizione del 1611 promossa dal governatore di Milano conte di Fuentes per il riordino delle botteghe sulla piazza del Duomo e il loro parziale spostamento presso il Verziere, della quale si occupò Alessandro Bisnati allora ingegnere sia del Comune che della Fabbrica del Duomo (gli studi di Ada Grossi hanno dimostrato che la disposizione delle strutture sulla piazza nel primo Seicento doveva tra l’altro corrispondere al consolidamento progressivo di una situazione creatasi in seguito alla grida di Ferrante Gonzaga del 1549, che già conteneva una disposizione assai simile; Grossi, 1997, pp. 147-151). Considerata la sostanziale identità della disposizione delle botteghe presente nel nostro disegno e in quelli della Raccolta Ferrari è possibile che anche il nostro registri lo stato di fatto del momento, confermando quindi una datazione al secondo decennio del XVII secolo, se non una paternità allo stesso Bisnati. Si aggiunga, inoltre, la presenza del piccolo studio a matita del catafalco collocato al centro della navata della cattedrale, che presenta la medesima forma e posizione di quello inserito nel disegno al f. 25rA del secondo tomo della Raccolta Bianconi e che rappresenta evidentemente un’aggiunta non si sa di quanto successiva. Non è chiaro, infatti, se il catafalco possa essere connesso con le esequie di Margherita d’Austria, morta nell’ottobre del 1611, oppure riferito a quelle del 1621 per Filippo III (in proposito Repishti, Schofield, 1999, pp. 98-101, n. 34), nel primo caso il disegno a penna dovrebbe essere necessariamente ricondotto a un momento anteriore o contemporaneo al 1611, mentre nel secondo caso esso non influirebbe nella datazione. In entrambi i casi, comunque, le esequie coinvolsero una personalità già menzionata in correlazione al nostro foglio, ovvero Tolomeo Rinaldi, che lavorò nel primo caso in associazione con Gaspare Baldovinio e nel secondo con Pietro Antonio Barca.
Bibliografia
L. Beltrami, Note di topografia dell’antico centro di Milano, Milano, 1912
Luca Beltrami e il Duomo di Milano. Tutti gli scritti riguardanti la cattedrale pubblicati tra il 1881 e il 1914, a cura di A. Cassi Ramelli, Milano, 1964, p. 437, fig. 48
P. Mezzanotte, Raccolta Bianconi. Catalogo ragionato. Tomo I, Milano, 1942, p. 40
F. Reggiori, Come si è arrivati alla piazza del Duomo quale oggi essa è, in Il Duomo di Milano, a cura di M.L. Gatti Perer, atti del convegno internazionale (Milano, 1968), Milano, 1969, II, p. 87, fig. 8
R. Wittkower, Gothic versus Classic. Architectural projects in Seventeenth Century Italy, New York, 1974, p. 37, fig. 11
I. Balestreri, I disegni del Duomo di Milano nella Raccolta Bianconi, “Il disegno di architettura”, 7, 1993, p. 24
La Raccolta Bianconi. Disegni per Milano dal Manierismo al Barocco, a cura di I. Balestreri, Milano, 1995, p. 22
Milano le chiese scomparse, a cura di M. Caciagli, Rozzano, 1997, p. 10
L. Patetta, Milano: XV-XVII secolo. La difficoltà di costruire piazze, in Fabbriche, piazze, mercati. La città italiana nel Rinascimento, a cura di D. Calabi, Roma, 1997, p. 64
P. Sanvito, Il tardogotico del duomo di Milano. Architettura e decorazione intorno all’anno 1400, Münster, 2002, fig. 5