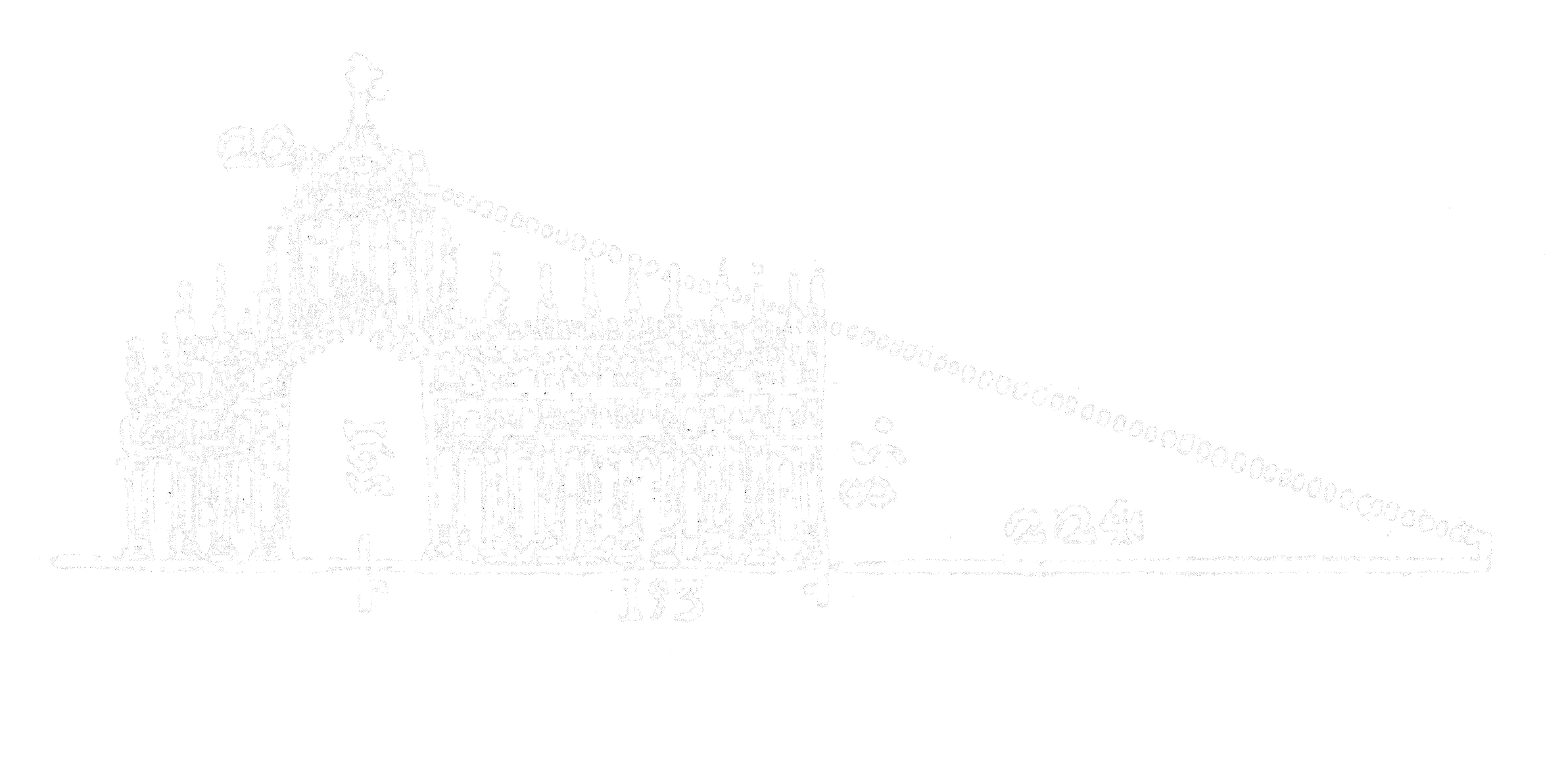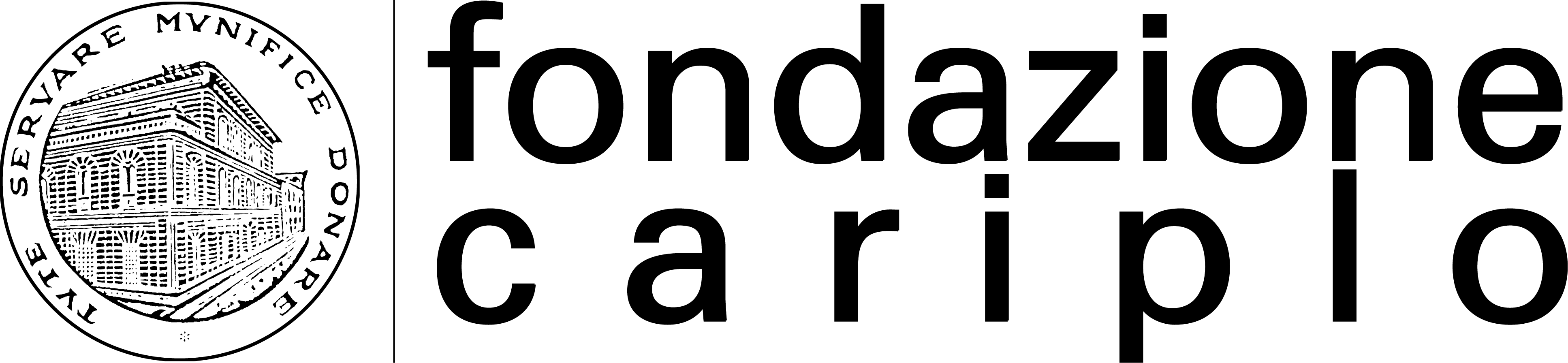«Progetto per la facciata del Duomo di Milano da unirsi alla sua relazione segnata A»
Autore
Galliori, GiulioTitolo
«Progetto per la facciata del Duomo di Milano da unirsi alla sua relazione segnata A»Datazione
XVIII secolo; 1786
Collocazione
AVFDMi, Archivio Disegni, 207
Dimensioni
920x623 mmTecnica e Supporto
Preparazione a matita, compasso; esecuzione a penna e inchiostro nero, acquarello giallo, rosa, acquarellatura a inchiostro nero diluito in varie sfumature di grigio; supporto cartaceo di media grammatura, filigrana non rilevabile, controfondato.
Scala
Al centro, tra pianta e prospetto, a penna e inchiostro nero, i numeri a penna e inchiostro bruno, di 90 braccia milanesi: costituita da un’asticella bipartita con tratti disposti a distanze regolari, più fitti in corrispondenza delle prime due unità, numerati 10, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70.Iscrizioni
In alto a centro, a penna e inchiostro bruno: «Progetto per la facciata del Duomo di Milano / da unirsi alla sua rel[azione] seg[nata] A».
In basso a destra, a penna e inchiostro bruno: «Giulio Galiori / Archit[ecto] della med[esi]ma 1786».
In corrispondenza della scala, a penna e inchiostro bruno: «Bra Milanesi».
Notizie
Il disegno appartiene a un gruppo di sei elaborati per la facciata di Giulio Galliori conservati presso l’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano (oltre a questo, AVFDMi, Archivio Disegni, 151, 208, 209, 210 e uno in AVFDMi, Archivio Storico, 152/32, fascicolo 9 ter). Rispetto agli altri cinque presenti presso la Fabbrica, il disegno mostra la pianta e il prospetto ortogonale della facciata, della quale sussistono due versioni analoghe, con minime varianti, una di dimensioni affini (AVFDMi, Archivio Disegni, 208) e una di dimensioni inferiori, allegata alla relazione autografa del maestro (AVFDMi, Archivio Storico, 152/32, fascicolo 9 ter). Ai prospetti di dimensioni maggiori corrispondono anche due prospetti laterali del fianco nord della cattedrale (AVFDMi, Archivio Disegni, 209 e 210), al secondo dei quali il n. 207 va associato. Le due coppie di elaborati si differenziano perché mostrano grafie e inchiostri parzialmente diversi nelle iscrizioni, nella prima coppia troviamo le iscrizioni della scala a inchiostro nero e solo l’iscrizione superiore a inchiostro bruno, nella seconda coppia troviamo la scala a inchiostro nero, ma con iscrizione a inchiostro bruno e grafia differente da quella dell’altra coppia. Un disegno di dimensioni più simili a quello dell’Archivio Storico, ma comunque maggiori, presenta una visione della fronte con alcune parti in prospettiva laterale (AVFDMi, Archivio Disegni, 151).
Il foglio si presenta fortemente imbrunito nella carta e una fascia più chiara lungo tutti i margini mostra che esso deve essere stato esposto per un certo periodo di tempo e inserito all’interno di una cornice. Il disegno è interamente controfondato, presentava alcune lacune piuttosto ingenti, specialmente nell’angolo inferiore sinistro e i margini irregolari in più punti. Si notano inoltre diversi strappi e macchie di brune.
La preparazione a matita interessa tutte le linee del disegno successivamente ripassate a penna, ma eccede leggermente i contorni del disegno stesso, è attualmente poco visibile a causa dell’imbrunitura globale del foglio: essa era, inoltre, composta da una griglia di quadrati e rettangoli di base, non è chiaro se la medesima per pianta e prospetto (non estesa però a tutto il foglio). Si nota altresì la presenza di una squadratura ai margini che individua il campo destinato al disegno, tuttavia solo nella parte riservata al prospetto, che è stata poi anche ripassata a penna e inchiostro nero. Il compasso, usato per la costruzione degli archi, mostra fori molto piccoli e poco visibili. L’esecuzione a penna è condotta con linee accurate e sottili; il disegno è interamente acquarellato, presenta un aspetto pittorico chiaroscurato, reso probabilmente utilizzando il medesimo inchiostro del tratto, diluito in diverse gradazioni (il colore grigio e la datazione del foglio farebbero sospettare che si tratti di inchiostro di china). Il disegno è condotto per la maggior parte a strumento, mentre a mano libera sono realizzati i particolari decorativi, per esempio tutte le archeggiature e cuspidi, accuratamente realizzate con fattura a drolerie dall’aspetto miniaturistico, sebbene seriali e un po’ rigide, la figura umana della statuaria è invece solo sommariamente abbozzata.
Note critiche
Questo disegno, datato e firmato, è forse il più noto tra quelli corrispondenti al progetto di Giulio Galliori, è stato infatti pubblicato da Giuseppe Morazzoni nel 1919 (Morazzoni 1919) e da Rudolf Wittkower nel suo volume Gothic versus classic (Wittkower 1974) e successivamente studiato nell’ambito della mostra E il Duomo toccò il cielo, curata da Ernesto Brivio e Francesco Repishti nel 2003. Esso corrisponde, come gli altri elaborati presenti presso la Fabbrica, a un progetto presentato da Galliori nel 1787 e accompagnato, oltre dalla citata relazione alla quale il disegno è allegato, da una lettera datata 6 ottobre (AVFD, Archivio Storico, 136). Il progetto è formulato dopo la nomina dell’autore ad architetto della Fabbrica, essendo succeduto a Francesco Croce nel 1773, ed è quindi relativo alla rinnovata fase di progettazione per la facciata del secondo Settecento, che seguì l’ultimazione della gran guglia, e che dovette dialogare con lo stato di fatto lasciato all’epoca di Carlo Buzzi e documentato dalla nota incisione di Marc’Antonio dal Re, che rappresenta i funerali di Polissena Giovanna Cristina regina di Sardegna del 1735.
Il disegno che qui vediamo sembra corrispondere nella sostanza a quello allegato alla relazione, del resto citata anche nell’iscrizione in testa a questo elaborato, e presenta quindi campiti in grigio i pieni murari esistenti, mentre sono eseguite a tratteggio le proiezioni delle volte sul piano, con acquerello rosso è indicata la facciata corrispondente al progetto in alzato, mentre in ocra le parti probabilmente da demolire. Queste indicazioni sono esplicitate all’interno della relazione che accompagna il foglio dell’Archivio Storico, dal titolo «Riflessioni critico-ragionate sopra della presente Facciata del Duomo di Milano, unitamente ad un Progetto che toglierebbe alcuni errori di fatto più sensibili, che presentemente si scorgono con spiacere de’ Professori, et Persone intendenti, ritenuto però le Porte, e Finestroni romani presentanei per essere opere travagliate eccellentemente». Nella relazione Galliori esprime anzitutto l’importanza del principio di conformità alla forma del Duomo, spiegando pertanto la preferenza per una soluzione “alla gotica” della facciata e come essa possa integrarsi con i finestroni e i portali già realizzati secondo il progetto di Pellegrino Tibaldi, rivisto da Francesco Maria Richino, e con i contrafforti gotici posti accanto alla porta maggiore, realizzati da Carlo Buzzi. Nel discutere il disegno illustra la scelta di distaccarsi dalle soluzioni che hanno proposto un portico largo quanto tutta la facciata, per prediligere invece un pronao che occupasse soltanto la larghezza della navata centrale (per non ingombrare eccessivamente), il quale avrebbe dovuto presentare anche una terrazza nella parte superiore. Galliori si concentra sulla forma specifica dei piloni, che a suo parere sarebbero dovuti essere identici a quelli dell’interno dell’edificio e spiega che, in corrispondenza delle navate minori, come si vede chiaramente nel disegno, si sarebbero dovute inserire strutture archiacute aggettanti dal filo di facciata e impostate su piloni come quelli del pronao. Queste ultime sarebbero state abbastanza sporgenti per sopravanzare le finestre alla romana e i portali già realizzati, che si sarebbero potuti in questo modo conservare (con la sola aggiunta al di sopra del portale maggiore di un ornamento alla romana recante un rilievo con la Natività della Vergine, intonato alla porta, per colmare il vuoto superiore ad essa). Contestualmente Galliori prevede la demolizione delle lesene "alla romana" ai fianchi della facciata, recuperando materiale dallo smontaggio per la realizzazione di altre parti e spiegando come lateralmente alla fronte sembrasse logico proporre la continuazione degli archi rampanti con gli acquedotti, che connotavano già i fianchi della cattedrale e che, infatti, sono presenti nel disegno.
Davide Tolomelli nota come il progetto sia particolarmente debitore verso quello di Carlo Giuseppe Merlo, in virtù dell’apprendistato compiuto dal maestro presso l’autorevole architetto milanese, soprattutto per l’idea delle strutture di raccordo tra le navate minori e il sopralzo della navata centrale, che nel progetto di Galliori sono tuttavia abbassate di quota, probabilmente per ovviare alle critiche che avevano colpito il progetto di Merlo rispetto a uno scarso slancio verticale della facciata stessa. Nello stesso senso sembrano orientati gli accorgimenti per conferire slancio al settore centrale e forse la decisione di optare per un pronao posto solamente in corrispondenza della navata maggiore, in luogo di un portico largo quanto l’intera fronte, prospettato per esempio nei disegni di Antonio Maria Vertemate Cotognola, di Giovanni Battista Riccardi, di Bernardo Vittone o dello stesso Merlo. Il progetto di Galliori fu fortemente criticato negli anni successivi, in particolare da Carlo Felice Soave, che si trovò di fatto a sostituire l’architetto nella conduzione della Fabbrica dopo l’8 agosto 1795, adducendo non poche osservazioni anche di carattere strutturale. La realizzazione della facciata stava del resto già proseguendo dal 1791 in base al progetto di Carlo Buzzi e con la demolizione di alcune delle parti eseguite “alla romana” (Annali, 1885, VI, p. 224; le lesene, ma non le finestre e le porte), proprio in base alle indicazioni di Soave. Sembra che a questo proposito Galliori abbia formulato una seconda proposta progettuale, della quale non sono sopravvissute testimonianze grafiche: un gruppo di disegni menzionati nella bibliografia a cura di Filippo Salveragio nel volume di Camillo Boito del 1889 (Boito 1889, p. XXI, n. 205) come esistenti presso la biblioteca di casa Trivulzio (Cod. Triv. 1412) non è oggi presente presso l’Archivio Storico Civico di Milano, come nel caso di altri materiali dubitativamente perduti durante il secondo conflitto mondiale.
Bibliografia
G. Morazzoni, Il Duomo. Saggio iconografico, Milano, 1919, p. 6, tav. X, fig. 18
L. Grassi, Province del Barocco e del Rococò. Proposta di un lessico bibliografico di architetti in Lombardia, Milano, 1966, p. 188
R. Wittkower, Gothic versus Classic. Architectural projects in Seventeenth Century Italy, New York, 1974, fig. 81
D. Tolomelli, Giulio Galliori, in E il Duomo toccò il cielo. I disegni per il completamento della facciata e l’invenzione della guglia maggiore tra conformità gotica e razionalismo matematico (1733-1815), a cura di E. Brivio, F. Repishti, catalogo della mostra (Milano, 2003), Milano, 2003, pp. 96-101